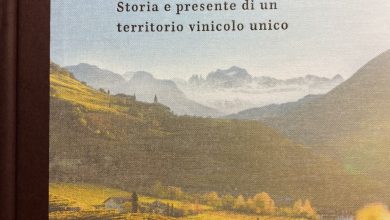Anime Euganee.
Sulla Strada della Biodiversità viticola sui Colli Euganei.

 “Un profilo audace di coni e cupole che s’intersecano sull’orizzonte della pianura che dal Po corre alle montagne e alle lagune: masse vulcaniche armoniose e ardite, insolenti quasi, lavorate da trenta milioni di anni di erosione selettiva. I colli Euganei sono un paesaggio essenziale, arcaico: un totem di potenza tellurica. Ogni colle è opera unica: frutto di un singolo evento eruttivo, e nei volumi e nelle pieghe e nel suo stare accanto agli altri manifesta un’anima intrinseca, un suo particolare eros impresso alla nascita dal contatto intimo tra calcari dell’antico mar della Tetide e magmi potenti venuti da sotto la crosta terrestre. Una duplice natura frutto dell’incontro di elementi opposti: acqua e fuoco!” Così il naturalista ed amico di G.R.A.S.P.O. Antonio Mazzetti descrive tutta la magia di questo territorio ricco di diversità e suggestioni.
“Un profilo audace di coni e cupole che s’intersecano sull’orizzonte della pianura che dal Po corre alle montagne e alle lagune: masse vulcaniche armoniose e ardite, insolenti quasi, lavorate da trenta milioni di anni di erosione selettiva. I colli Euganei sono un paesaggio essenziale, arcaico: un totem di potenza tellurica. Ogni colle è opera unica: frutto di un singolo evento eruttivo, e nei volumi e nelle pieghe e nel suo stare accanto agli altri manifesta un’anima intrinseca, un suo particolare eros impresso alla nascita dal contatto intimo tra calcari dell’antico mar della Tetide e magmi potenti venuti da sotto la crosta terrestre. Una duplice natura frutto dell’incontro di elementi opposti: acqua e fuoco!” Così il naturalista ed amico di G.R.A.S.P.O. Antonio Mazzetti descrive tutta la magia di questo territorio ricco di diversità e suggestioni.
 La sua promozione e la sua valorizzazione è tra gli obiettivi principali della dinamica Strada del Vino dei Colli Euganei guidata oggi da Roberto Giardina che ha organizzato nella splendida corte all’italiana di Villa dei Vescovi la quarta edizione di “Vini Euganei: eccellenze enologiche in Villa”.
La sua promozione e la sua valorizzazione è tra gli obiettivi principali della dinamica Strada del Vino dei Colli Euganei guidata oggi da Roberto Giardina che ha organizzato nella splendida corte all’italiana di Villa dei Vescovi la quarta edizione di “Vini Euganei: eccellenze enologiche in Villa”.

Un’occasione unica per degustare i vini di 25 cantine euganee, selezionate per l’evento da una commissione di produttori, professionisti, ristoratori ed esperti del mondo vitivinicolo. Ogni cantina presenta tre vini per raccontare le migliori produzioni enologiche dei Colli Euganei.
Un appuntamento strategico per conoscere un terroir unico come quello dei Colli Euganei, degustare le migliori etichette, incontrare i produttori e acquistare i loro vini.
Ma anche una bella occasione per condividere con produttori, sommelier ed appassionati il suggestivo racconto di G.R.A.S.P.O. sull’identità ampelografica di questo unicum vitivinicolo.

Un racconto che parte da lontano come evidenziato da Luigino Bertolazzi nella sua introduzione alla degustazione.
Prima della fillossera, la configurazione ampelografica dell’Italia era ben diversa dall’attuale e ancora di più nel comprensorio padovano.
In ogni zona viticola esisteva un gran numero di cultivar sia a bacca bianca, rossa e anche rosata.
Tali vitigni si erano andati selezionando nel corso dei secoli da viti indigene, o erano stati importati da altri paesi e successivamente diffusi in una determinata zona.
Importante è stata all’inizio una forma empirica di selezione massale, la quale ha fatto in modo che fossero propagate popolazioni che riunivano in sé particolari pregi di qualità, di produzione, di adattabilità alle condizioni colturali pedologiche e climatiche di un determinato ambiente.
Tale processo, spesso, è durato per secoli e ciò fa immaginare il valore che venivano ad avere le cultivar una volta che era stata riconosciuta la loro validità di coltivazione.
Si poteva allora disporre in sostanza di un patrimonio genetico adatto di grande valore.
La comparsa della Fillossera ha rivoluzionato in molte zone d’Italia questa situazione ampelografica, sia eliminando i vitigni che con l’innesto manifestavano limiti o scarsa affinità, sia introducendo vitigni da altri paesi in particolare dalla Francia e dalla Germania.
Purtroppo per improvvisazione e anche scarsa competenza si è proceduto a introdurre o scartare un vitigno non sempre basandosi su dati rigorosamente scientifici, frutto di prove sperimentali, bensì su elementi spesso soggettivi o poco ponderati.
È accaduto così che un grande patrimonio genetico sia andato perduto o si sia ridotto ad un numero molto esiguo di esemplari destinati purtroppo all’estinzione.
Una riflessione che coincide con quanto riportato nel 1978 da Giuseppe Tocchetti in una sua pubblicazione sui vecchi vitigni da vino del padovano dove sottolineava che solo poche cultivar diffuse allora sono oggi ancora presenti come Friularo , Moscato fior d’arancio, Garganega , Pinella, Serprino, Marzemina bianca e poche altre.
Evidente quindi che anche le vecchie cultivar padovane, ora in gran parte quasi estinte, possano racchiudere in sé quell’importante patrimonio genetico che se debitamente riscoperto, studiato e valorizzato, potrebbe portare ancora notevoli vantaggi alla viticoltura e all’enologia della provincia.
L’opera meritoria e visionaria di Tocchetti è diventata quindi utile per attivare in modo pianificato ed organico una serie di iniziative da parte del Crea di Conegliano con il supporto di Veneto Agricoltura su tutta la Regione ma con occhio di riguardo per l’areale ed i vitigni dei Colli Euganei anche con il supporto di custodi visionari come Giorgio Salvan, Franco Zanovello, Ivano Giacomin e Mario Dal Betto.
Così la degustazione di Dorona, Pedevenda, Vernazola, Doretta o Quaiara, Corbina, Cavarara Garbina, e Marzemina Nera Bastarda è diventata una occasione straordinaria per riflettere sulle potenzialità di queste uve …scampate agli ultimi concitati decenni di viticoltura intensiva ritrovate e microvinificate da GRASPO.
La Dorona di Venezia ha sicure radici in terra ferma, un bianco potente ed armonioso da sempre presente sui Colli, la Pedevenda qui chiamata anche Verdise ha nel suo nome un chiaro marchio di origine : ai Piè del Venda, fresco e gioioso, la Vernazola o Vernanzina chiude in bellezza il trittico ideale dei bianchi Euganei.
Incroci pericolosi sempre sui Colli con due vitigni fondativi come il Liseiret e la Vulpea o Quaiara qui chiamata anche Doretta o Sciavetta con una varietà originalissima che deriva da un loro fortunato incrocio naturale, la Piccola Nera un rosa acceso e fragrante.
Gran finale poi con tre rossi di carattere e temperamento con la Cavarara Garbina, la Corbina e la Marzemina Nera Bastarda che nel suo nome già racconta la sua indomabile indole.
Una occasione concreta per fare il punto della situazione, capire quali varietà possono già essere interessanti per la coltivazione essendo consentite per questo suggestivo territorio, quali devono essere ancora autorizzate e quali non sono ancora iscritte al Registro del Ministero.
I colli Euganei, ha concluso Bertolazzi, sono una realtà geografica e climatica ben precisa, con una classe geomorfologica unica nel panorama collinare italiano, da sempre in grado di dare produzioni agricole di alta qualità e forte identità. Il cambiamento climatico in atto impone lungimiranza e scelte coraggiose. Servirà ripensare a una maggior presenza dell’uomo in campo e al senso di “custodia del passato”: in questi anni stanno prendendo vigore idee di recupero colturale delle vecchie varietà: specie intriganti, ricche di sorprese e novità, magari da interpretare con nuove forme d’impianto, in grado di mitigare gli eccessi del clima, e più naturali lavorazioni in cantina, capaci di restituire profumi più aperti e sinceri, sapori più vitali e imprevedibili. Un aggiornamento anche di biodiversità culturale che, con un occhio al passato, apra a visioni creative del futuro che sarà…
Il viaggio continua
Aldo Lorenzoni e Luigino Bertolazzi
Foto di Gianmarco Guarise
Ci trovate su:
Facebook e Instagram, alla voce Associazione Graspo
Strada del vino Colli Euganei
Viale Stazione, 60, 35036 Montegrotto Terme PD
https://www.stradadelvinocollieuganei.it
Grazie per aver letto questo articolo...
Da 15 anni offriamo una informazione libera a difesa della filiera agricola e dei piccoli produttori e non ha mai avuto fondi pubblici. La pandemia Coronavirus coinvolge anche noi. Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, è semplicemente ridotta e non più in grado di sostenere le spese.
Per questo chiediamo ai lettori, speriamo, ci apprezzino, di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, può diventare Importante.
Puoi dare il tuo contributo con PayPal che trovi qui a fianco. Oppure puoi fare anche un bonifico a questo Iban IT 94E0301503200000006351299 intestato a Francesco Turri