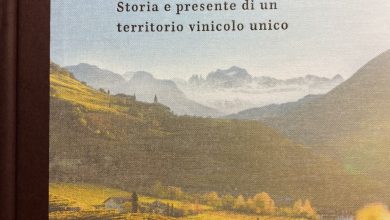Senarum Vinea con i profeti di GRASPO prima di GRASPO

La diversità biologica della vite coltivata è il risultato di migliaia di anni di selezione, è un’eredità che la natura e la storia ci hanno lasciato e che non può essere ricreata in laboratorio, una volta distrutto questo capitale non potrà essere ricostituito e sarà perso per sempre.
Se si vuole quindi conoscere la storia di un territorio viticolo attraverso le vicende che hanno accompagnato l’affermazione dei suoi vini, è necessario una ricerca che parta dai suoi vitigni originali, perché solo attraverso questi è possibile comunicare l’originale identità di un territorio, degli uomini che lo abitano, della loro evoluzione culturale, delle risposte ai cambiamenti climatici e dei sistemi sociali adottati.
I vitigni infatti sono gli elementi stabili per una infinità di generazioni di viticoltori.
Su questi fondamentali concetti nasce nel 2020 G.R.A.S.P.O. che si occupa da allora del recupero dei vitigni rari italiani.

E se la stessa fondamentale riflessione fosse stata, 15 anni prima, alla base di un innovativo progetto di recupero di vitigni identitari che potessero ri-raccontare la storia di una città e di tutta la sua comunità?
Siamo a Siena con tre persone veramente toste e preparate come l’agronomo Valerio Zorzi, l’archeologo Andrea Ciacci e l’enologo Paolo Brogioni che avevano in testa nel 2007 un’idea precisa ovvero la riqualificazione storico-paesaggistica e ambientale di Siena e delle sue valli, attraverso il recupero delle cultivar storiche e degli ordinamenti colturali che le caratterizzano.
Un progetto poi consolidato e realizzato nel tempo grazie anche al sostegno delle Istituzioni con il nome di Senarum Vinea.
Veri e propri profeti di quella che sarebbe stata l’azione di GRASPO…prima di GRASPO

A raccontarci la genesi di questo sogno è Andrea Ciacci in occasione dell’ultima tornata dell’Accademia della Vite e del Vino presso l’iconica sede ritrovata dell’Enoteca Italiana.
Dall’archeologia alla storia, dall’iconografia all’ampelografia, dalla botanica all’ingegneria dell’informazione fino alla biologia molecolare, Senarum Vinea è un progetto interdisciplinare, e qui sta buona parte del suo grande valore, che come obiettivo originario aveva l’individuazione di un percorso storico attraverso la mappatura topografica e genetica dei vitigni più antichi che da secoli crescono all’interno delle mura di Siena e negli spazi rurali suburbani.
Le antiche Gabelle e la ricca documentazione custodita dagli Enti religiosi, insieme alle testimonianze iconografiche del territorio senese con le relative tecniche di coltivazione della vite e lo studio della cartografia storica di Siena, hanno permesso di individuare i tanti orti urbani presenti all’interno dei conventi e delle contrade ma anche poderi suburbani, che hanno fatto sì che la città, soprattutto nel suo settore meridionale, mantenesse inalterato un profilo unico ed autentico, in cui si conservano tracce di vigneti destinati a produzioni di vino limitate ad un consumo familiare.

L’indagine è stata condotta, in particolare, nelle clausure dei complessi conventuali, nei giardini delle Contrade e negli appezzamenti ortivi urbani e suburbani che recano ancora traccia di forme storiche della viticoltura senese.
Si chiamano Gorgottesco, Tenerone, Salamanna, Prugnolo gentile, Occhio di pernice, Procanico, Rossone, Mammolo, ci spiega Valerio Zorzi che ha seguito direttamente tutte le fasi del progetto, e questi si distinguono dai vitigni più noti soprattutto per una particolarità: da centinaia di anni il loro terroir d’elezione è la città di Siena.

E questi sono solo alcuni dei più antichi vitigni che la città ha riscoperto grazie a Senarum Vinea tanti altri assolutamente originali attendono ancora un nome ed un futuro.
Abbiamo iniziato questo percorso di ricerca partendo dai vigneti più vecchi ritrovati nelle clausure dei complessi conventuali, nei giardini delle Contrade e negli appezzamenti ortivi urbani e suburbani che recano ancora traccia di forme storiche della viticoltura senese.

Il carattere privato e chiuso di tali spazi verdi, assieme alle dimensioni spesso limitate, li ha sottratti alle modifiche introdotte dall’agricoltura meccanizzata e alle suggestive e moderne tecniche di coltivazione.
Senarum Vinea rappresenta una storia di successo, racconta quasi emozionato Paolo Brogioni, oggi direttore di Assoenologi ma al tempo insegnante presso l’Istituto Ricasoli al centro del Progetto, perché è stata messa a punto una metodologia d’indagine facilmente replicabile, i cui risultati consentono di mettere meglio a fuoco le possibili matrici storiche del paesaggio vitato senese, ma anche perché il coinvolgimento di più enti e istituzioni ha creato i presupposti per la condivisione di progettualità ed obiettivi.

Tra questi appunto oltre all’Associazione Città del Vino, l’Istituto Agrario di Siena che ha offerto la disponibilità ad accogliere il campo del germoplasma e a partecipare alle fasi di microvinificazione; la Cooperativa sociale ONLUS “La Proposta” che ha messo a disposizione il campo di conservazione per accogliere i vitigni antichi.
Siena ha di nuovo il suo vigneto in città, spiega Zorzi accompagnandoci nella visita presso l‘Orto de’ Pecci, nella valle di Porta Giustizia, le prime 149 barbatelle di alcuni dei più antichi e rari vitigni – dal Gorgottesco al Tenerone, dal Mammolo alla Salamanna, dal San Colombano al Procanico al Prugnolo gentile, oltre a 9 varietà a bacca bianca e rossa ancora da identificare – recuperati nel corso di sopralluoghi del Progetto all’interno delle mura e negli spazi suburbani della città medievale.

Il campo di conservazione ha forma rettangolare e un’estensione pari a 500 metri quadrati; ospita dieci filari di 20 viti ciascuno, per un totale di 200 piante.
Il campo prevedeva da progetto un’estensione di 1.000 mq e la messa a dimora di 400 viti; si è provveduto a ridimensionarne l’area e a ridurre della metà il numero di viti per consentire la piantumazione di parte del materiale vegetale anche presso l‘Istituto Tecnico Agrario Statale “Bettino Ricasoli di Siena.
Il campo ha lo scopo di produrre il materiale vegetale (gemme) destinato a generare le barbatelle da mettere a dimora nei vigneti delle aziende interessate alla produzione.
Il campo di conservazione è stato allestito con antichi sistemi a sostegno morto tipo alberello.
Sostanzialmente lo stesso schema di impianto è stato adottato anche presso l’Istituto Agrario di Siena “Bettino Ricasoli” puntualizza Brogioni che ci accompagna nella visita.
Lusinghieri ricorda anche i risultati enologici nell’ambito delle prime microvinificazioni realizzate nell’ambito del progetto.
Il Giacchè presenta un colore rosso rubino con unghia violacea; profumo intenso e pulito, con note di frutta rossa, ciliegia sotto spirito, prugna; vino con ottima beva, con struttura bilanciata, frutta in evidenza, lungo e morbido.
Anche il Gorgottesco presenta un colore rosso rubino tendente al violaceo; profumo meno intenso ma fruttato, vino di buona beva, di media struttura, con caratteristico retrogusto amarognolo.
In entrambi i casi sono considerati di estremo interesse sia per una produzione monovitigno che come varietà da uvaggio.
Il vitigno 7CM ha un colore rosso rubino intenso, di trama antocianica fitta, con unghia violacea, limpido;
dal profumo poco intenso ma con aromi secondari di frutta rossa; di scarsa struttura, ma persistente e acidità malica in evidenza; varietà con le caratteristiche del vino da taglio, ricco di colore e con buona acidità.
Vitigni che arrivano dal passato di una città e che possono ridisegnarne il futuro.
Il viaggio continua.
Di Aldo Lorenzoni e Luigino Bertolazzi, foto di Gianmarco Guarise
Ci trovate su:
Facebook e Instagram, alla voce Associazione Graspo
Grazie per aver letto questo articolo...
Da 15 anni offriamo una informazione libera a difesa della filiera agricola e dei piccoli produttori e non ha mai avuto fondi pubblici. La pandemia Coronavirus coinvolge anche noi. Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, è semplicemente ridotta e non più in grado di sostenere le spese.
Per questo chiediamo ai lettori, speriamo, ci apprezzino, di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, può diventare Importante.
Puoi dare il tuo contributo con PayPal che trovi qui a fianco. Oppure puoi fare anche un bonifico a questo Iban IT 94E0301503200000006351299 intestato a Francesco Turri